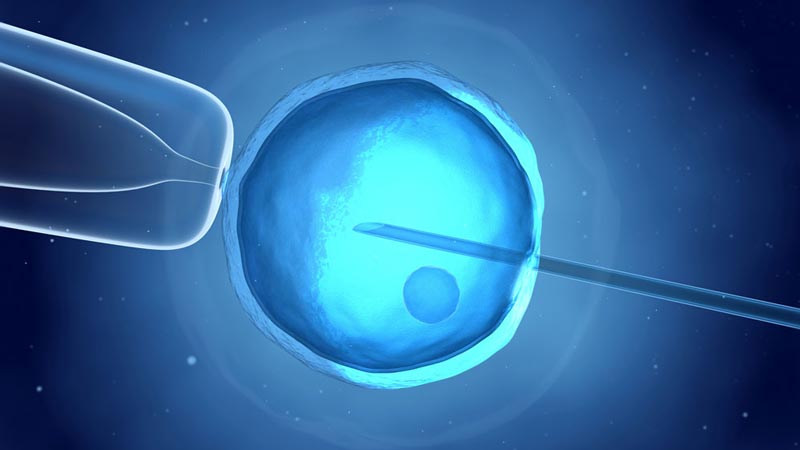Traccia Parere Civile Nr. 2 – Esame Avvocato 2018
Tizio gioca una partita a poker con qualche sconosciuto, nel corso del quale viene bevuta da tutti una consistente quantità di whisky. All’esito della mano finale Tizio perde l’importo di euro 1.000 in favore di Caio.
Non avendo con sé tale importo, chiede ed ottiene due ore di tempo per saldare il debito, ma non riesce a procurarsi la somma necessaria. Pertanto dietro pressioni di Caio e degli amici di quest’ultimo che avevano partecipato alla partita, sottoscrive una dichiarazione la quale prometteva il pagamento della vincita a Caio entro le successive 48 ore.
Dopo aver pagato la soma, però, Tizio si rivolge al proprio legale rappresentando che gli altri giocatori avevano barato al gioco e che la promessa di pagamento gli era stata estorta dietro minacce di gravi ripercussioni alla propria integrità fisica.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere esaminando le questioni sottese al caso e e individuando le varie possibilità di tutela offerte dall’ordinamento.
Soluzione proposta – Parere Civile Nr. 2
La traccia richiede di analizzare preliminarmente le obbligazioni naturali in relazione al debito di gioco (art. 1933 c.c.) e la promessa di pagamento (1988 c.c.) e conseguentemente di accertare quali rimedi siano esperibili da parte di un soggetto tenuto al pagamento di una somma di denaro persa durante una partita di poker.
Il debito di gioco è un’ipotesi tipizzata di obbligazione naturale, disciplinata dall’art. 2034 c.c., secondo il quale: “non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato non producono altri effetti”.
Sono obbligazioni naturali i doveri morali e sociali che costituiscono l’espressione di valori condivisi dalla generalità dei consociati; vengono tradizionalmente definite come obbligazioni imperfette perché la legge non accorda un’azione per ottenerne l’adempimento, ma esclude la ripetizione di quanto spontaneamente pagato.
Esse dunque rilevano giuridicamente solo nel momento in cui vengono adempiute.
Con particolare riferimento al debito di gioco, l’art. 1933 c.c. prevede che “non compete azione per il pagamento di un debito di gioco o di scommessa, anche se si tratta di un gioco o di una scommessa non proibiti”.
La stessa norma sancisce, peraltro, che: “Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode“.
Dunque, l’Ordinamento italiano, considera il debito di gioco come un’obbligazione naturale e di conseguenza non attribuisce azione per ottenerne il pagamento; tuttavia, qualora il debitore adempia, il codice individua tre presupposti alternativi tra loro che gli consentono di agire per la ripetizione:
- l’assenza di spontaneità del pagamento
- la frode da parte degli altri giocatori, intesa come slealtà o scorrettezza, che comporta l’irregolarità del gioco e fa venire meno la doverosità morale o sociale dell’adempimento dell’obbligazione naturale;
- l’incapacità del giocatore che ha adempiuto il pagamento, intesa con riferimento alla capacità di intendere e di volere.
Qualora uno dei presupposti sopra indicati manchi, il solvens può agire per la ripetizione della prestazione.
La questione si complica nel caso in cui il giocatore che abbia perso, sebbene in stato di ubriachezza, dunque trovandosi in stato di incapacità di intendere e di volere e nonostante la condotta fraudolenta degli altri giocatori, si impegni con una successiva promessa al pagamento del debito di gioco.
In questo caso trova applicazione la disciplina degli articoli 1987 e 1988 c.c.
L’art. 1988 c.c., in particolare, disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito (considerate come sinonimi dalla dottrina, posto che chi promette di pagare riconosce un debito).
La promessa di debito è l’atto unilaterale con cui un soggetto promette il pagamento di una determinata somma nei confronti di un altro.
Sulla natura giuridica della promessa di pagamento si confrontano due orientamenti:
- secondo un primo orientamento si tratta di un negozio unilaterale di accertamento fonte di obbligazioni;
- secondo altra dottrina e secondo la giurisprudenza prevalente, invece, non è una fonte di obbligazione ma piuttosto una dichiarazione di scienza con efficacia probatoria (astrazione processuale) che innesca un’inversione dell’onere probatorio, esonerando il beneficiario della dichiarazione dalla prova dell’esistenza del rapporto obbligatorio che viene dunque presunto e spostando in capo all’autore della dichiarazione la prova contraria in merito all’inesistenza della fonte del rapporto. L’effetto che questa comporta non è infatti l’assunzione di un obbligo quanto, piuttosto, quello di realizzare un’inversione dell’onere della prova: sarà lo stesso soggetto dichiarante a dover provare, eventualmente, la illiceità, invalidità o inesistenza del rapporto sottostante sulla base del quale è stata fatta la dichiarazione.
In questo senso Cass. civ. 4019/2006: “La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. – nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate – un’astrazione meramente processuale della causa, comportante l’inversione dell’onere della prova, ossia l’esonero del destinatario della promessa dall’onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l’onere di provare l’inesistenza o la invalidità o l’estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l’adempimento dell’obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l’onere di provare la inesistenza o la invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale“.
Pertanto, la promessa di pagamento deve essere sempre collegata ad un altro negozio che la giustifichi causalmente.
Qualora manchi un titolo che giustifichi causalmente il pagamento, colui che ha adempiuto può chiedere l’accertamento dell’inesistenza, nullità o illiceità del rapporto fondamentale e ripetere la somma pagata sulla base dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Le due norme menzionate (art. 1933 c.c. e 1988 c.c.) si attagliano perfettamente al caso di specie.
Dai dati offerti dalla traccia emerge infatti che Tizio ha partecipato ad una partita a poker con degli sconosciuti, nel corso della quale tutti hanno bevuto una consistente quantità di whisky.
Il conseguente stato di incapacità di intendere e di volere in cui si è trovato Tizio a causa dell’alterazione provocata dall’assunzione di alcool consente di ritenere integrato un presupposto da solo sufficiente per ammettere la ripetizione della somma corrisposta (l’incapacità, di cui all’art. 1933 comma 2 c.c. e 2034 comma 1 c.c.).
Inoltre, ricorre un ulteriore presupposto a fondamento della ripetibilità della prestazione richiesto dagli artt. 1933 comma 2 e 2034 comma 2 c.c.: infatti, Tizio non ha adempiuto spontaneamente, bensì su coazione degli altri giocatori, che avevano minacciato gravi ripercussioni alla sua integrità fisica.
Infine, dalla traccia emerge che gli altri giocatori hanno barato, integrando un’attività fraudolenta che ha pregiudicato il corretto svolgimento del gioco. Ricorre dunque un ulteriore presupposto individuato dall’art. 1933 comma 2 c.c. per ammettere la ripetizione del debito di gioco.
La ratio è evidentemente quella di non assicurare alcuna forma di tutela ad obblighi morali sorti nei confronti di soggetti che abbiano agito in modo moralmente scorretto.
A nulla rileva che Tizio si sia impegnato successivamente al pagamento della somma di 1.000,00 euro nei confronti di Tizio, perché, come sostenuto dalla giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. civ. 4019/2006), la promessa di pagamento non è un negozio giuridico dotato di una propria causa autonoma bensì integra semplicemente un’astrazione processuale e deve trovare una propria giustificazione causale in un altro negozio giuridico.
Poiché l’obbligazione naturale a monte è priva di una giustificazione causale giuridicamente rilevante, la promessa di pagamento è improduttiva di effetti.
Inoltre, la disciplina di cui all’art. 1933 c.c. è estendibile a fattispecie come le dazioni di denaro, di fiches, promesse di mutuo e riconoscimenti di debito, qualora le stesse risultino funzionalmente collegate all’attuazione del gioco o della scommessa (Cass. civ. 02/04/2014 n. 7694).
Pertanto Tizio può agire in giudizio per ottenere una sentenza di condanna alla restituzione della somma di 1.00,00 euro pagata a Caio ai sensi dell’art. 2033 c.c. e che accerti incidentalmente l’inefficacia della promessa di pagamento, coerentemente con quanto affermato dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione.